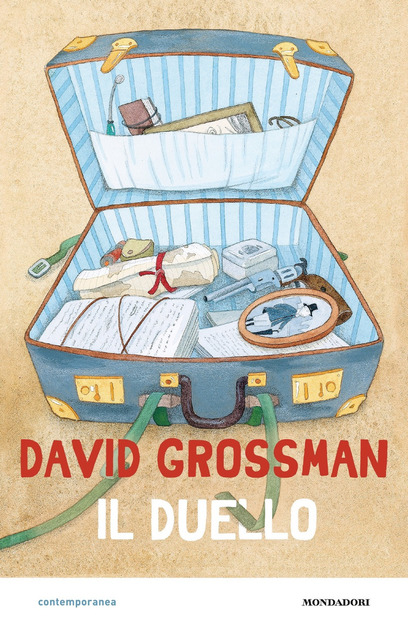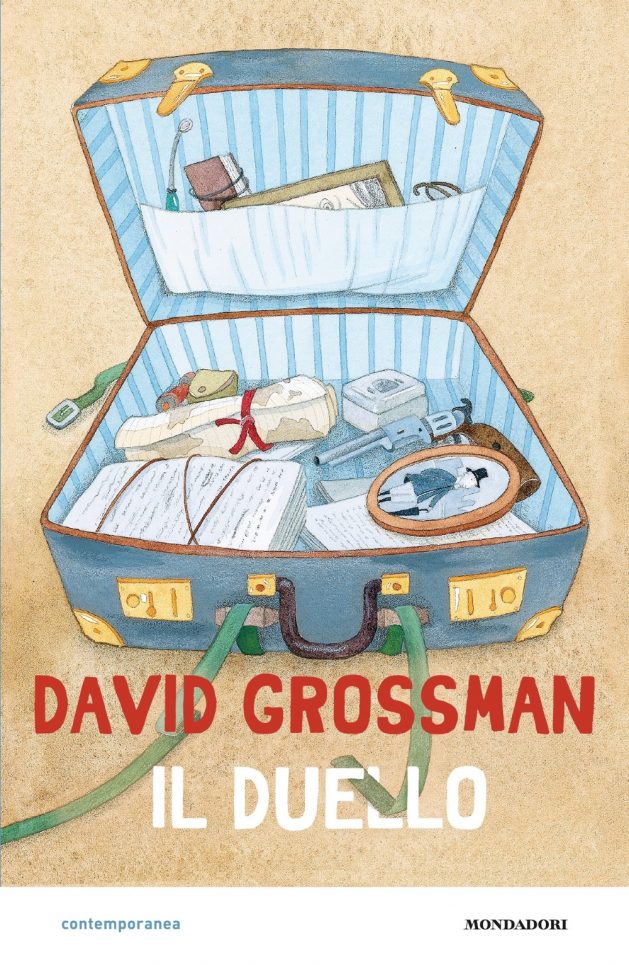Regia di Radu Mihaileanu. – Francia, Belgio, Romania, Israele, Paesi Bassi, 1998, durata 103 minuti. Età +16

- SINOSSI
- RECENSIONE
- VIDEO
- SINOSSI
Una sera del 1941 Schlomo, chiamato da tutti il matto, irrompe allarmato in un piccolo villaggio ebreo della Romania: i nazisti, fa sapere, stanno deportando tutti gli abitanti ebrei dei paesi vicini e fra poco toccherà anche a loro. Durante il consiglio dei saggi, che subito si riunisce, Schlomo tira fuori una proposta un po’ bizzarra che però alla fine viene accolta: per sfuggire ai tedeschi, tutti gli abitanti organizzeranno un falso treno di deportazione, ricoprendo tutti i ruoli necessari, gli ebrei fatti prigionieri, i macchinisti, e anche i nazisti in divisa, sia ufficiali che soldati. Così riusciranno a passare il confine, ad entrare in Ucraina, poi in Russia per arrivare infine in Palestina, a casa.
2. RECENSIONE
C’era una volta….
Con queste parole comincia il film di Radu Mihaileanu. Un racconto che ha un sapore fiabesco. Protagonista assoluto il treno, come metafora del viaggio verso qualcosa o in fuga da qual cosa.
Per capire questa fuga forse bisogna stare attenti alle prime parole del film, pronunciate da Schlomo, il pazzo o scemo del villaggio (ruolo pensato in un primo tempo per Benigni), mentre lo si vede correre forsennatamente. Dice Schlomo: “Fuggivo, credevo si potesse fuggire da ciò che già si è visto, troppo visto…”. E’ questa probabilmente la stessa cosa in cui ha creduto il regista Radu Mihaileanu quando, dopo aver visto Schindler’slist, ha deciso di girare a modo suo un film sulla shoah, tutto questo in concomitanza a quello che faceva Roberto Benigni in Italia girando “La vita è bella”. L’orrore messo in scena da Spielberg con la sua “lista di Schindler” aveva toccato il massimo. Dopo essersi sporcati troppo gli occhi nel presentare gli orrori delle deportazioni naziste, ora, fa intendere Mihaileanu, bisogna ripulirseli. “Come lavare gli occhi insudiciati, gli occhi che hanno visto troppo…”, si chiede Schlomo sempre all’inizio del film. Lui fin dall’inizio fugge: ma da cosa? Lo sapremo veramente soltanto alla fine del film. Sarà la risposta all’altra frase iniziale: “Lo spazio non è più nei nostri cuori, e noi andremo a cercarlo altrove…”. Train de vie è un film su questo “altrove”, su questo altro spazio possibile per chi non ne trova più nel proprio cuore. E il treno è il mezzo per raggiungere questo luogo-altrove. Dentro questo treno c’è la storia dell’ebraismo con le sue ambivalenze storiche: da una parte l’accusa di Hitler agli Ebrei di essere dei Bolscevichi e contemporaneamente dei Capitalisti intrusi nel sistema economico europeo. Nel treno del film c’è anche l’amore, la famiglia, la tradizione religiosa del popolo ebreo, ma soprattutto il senso dell’umorismo. Gli ebrei di questo treno della vita, infatti, parlano una lingua, che, come dice uno dei protagonisti del film, è nient’altro che la parodia del tedesco con dentro l’umorismo: si tratta della lingua Yiddish, la lingua degli Ebrei del Centro Europa, lingua di una ormai piccola minoranza che presenta però scrittori della statura del premio Nobel Isaac B. Singer o del filosofo Martin Buber, autore, tra l’altro di una raccolta di racconti della cultura yiddish.
La cultura dei villaggi (shtetl) Yiddish è ironica, sferzante. E’ la risposta polemica del regista ad un certo modo ebraico di trattare i fatti della Shoah.
“Quando vedo certi programmi televisivi cupi e noiosi sulla Shoah, quando sento i piantie i lamenti, penso sempre: se Hitler fosse vivo e vedesse questa roba, sarebbe felice. L’unica cosa con la quale possiamo umiliare i gerarchi nazisti che sono ancora vivi in Sudamerica, e farli imbestialire, è mostrare loro che siamo vivi, non ci hanno distrutti, che il nostro umorismo non è stato cancellato dalla loro barbarie” (da un’intervista a Mihaileanu).
L’inizio e la fine del film ripropongono il modo Yiddish di raccontare le storie. All’inizio: “Amol iz geven, C’era una volta”. E alla fine: “S’iz an emese mayse, Questa è una storia vera”. E il narratore, Schlomo, corrisponde allo schnorrer, che è una delle figure più tipiche della società e della letteratura yiddish. In principio era essenzialmente un saltimbanco e un musicista, ma anche un predicatore itinerante. Poi è diventato un cantastorie.
Nel film è lui il motore della storia, che da risposta alle domande del popolo del villaggio e che pone allo spettatore le grandi domande sull’esistenza.
3. VIDEO
Train de vie ITA – Musica tra ebrei e zingari
Train de vie – Monologo
Train de vie: conflitto ebrei-nazisti