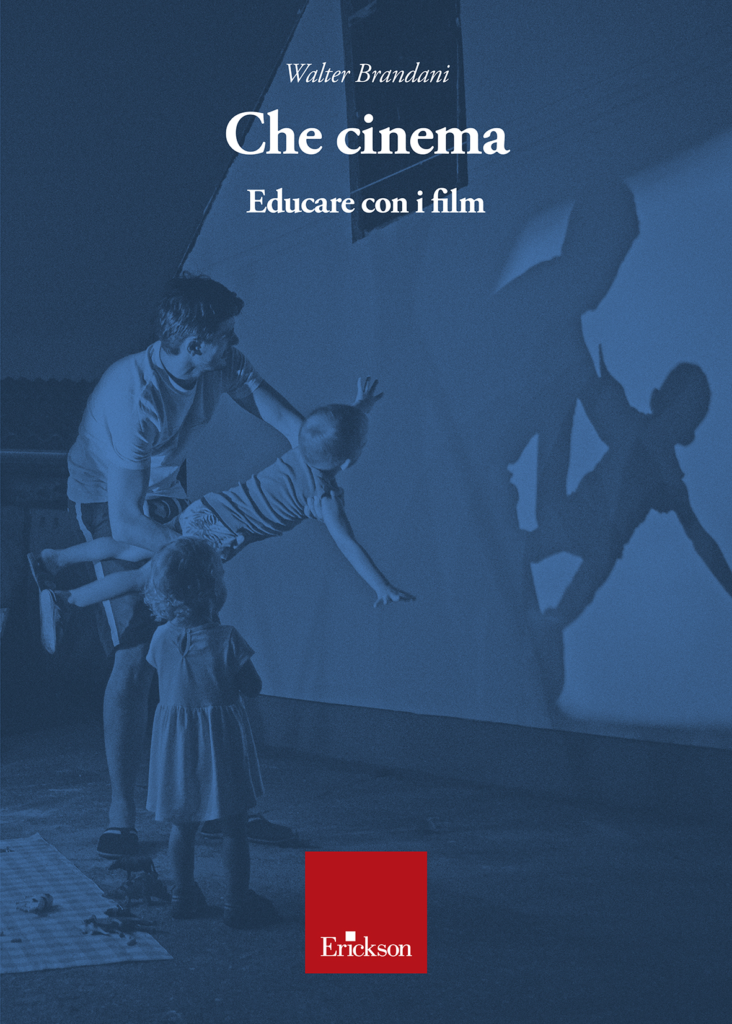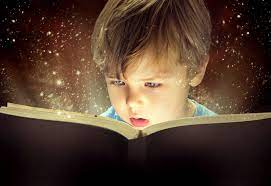Regia di Agnieszka Holland
– durata 147 min.
– Polonia, Germania, Francia, Belgio 2023
– Età dai 14 anni
TRAMA
Nelle gelide foreste che ricoprono il confine tra la Bielorussia e la Polonia, teatro dal 2021 della crisi migratoria istigata dal governo bielorusso, si incrociano le vicende di una famiglia di rifugiati siriani che lotta per attraversare il confine, della loro compagna di viaggio afghana, di una giovane guardia di frontiera polacca che sta per avere un bambino e di un gruppo di attivisti che aiuta i migranti respinti al confine.
RECENSIONE
Annalisa Camilli, internazionale.it
“Ho cominciato a girare Green border pochi mesi dopo che il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko aprisse una specie di corridoio per i profughi verso la Polonia. È stata la prima volta che la violenza e i respingimenti al confine polacco sono stati tollerati in questa forma in Europa”, afferma Agnieszka Holland, regista e sceneggiatrice del film, nelle sale italiane dall’8 febbraio. La contatto su Zoom, mentre è a Parigi e sta lavorando al suo nuovo progetto.
“Ovviamente respingimenti di questo tipo ai confini europei si verificavano anche prima: in Grecia, Croazia, Italia e Francia. Ma questa volta mi è sembrato che ci fosse un accordo generale sul fatto di permetterli, sono stati ‘normalizzati’. Il piano di Lukašenko era molto chiaro: voleva usare i profughi come un’arma di pressione, lo aveva già fatto in passato per minacciare la stabilità e l’integrità dell’Europa. E ci è riuscito”, continua la regista.
Holland, 75 anni, è forse la più famosa tra i registi polacchi e nel suo ultimo film ha usato il linguaggio cinematografico per mostrare la realtà, come non erano riusciti a fare i giornalisti e i documentaristi che hanno provato a raccontare la stessa vicenda: migliaia di famiglie condotte con l’inganno in Bielorussia dalla Siria e dall’Iraq con dei voli di stato e poi abbandonate al confine con la Polonia, nella foresta di Białowieża, nell’inverno 2021.
Il film che ha fatto infuriare il governo polacco
“Il cinema è il mio linguaggio, così ho immediatamente trasformato in finzione la realtà. È il mio lavoro: trovare un aspetto universale nelle questioni particolari e soggettive”, spiega la regista, che con Green border ha vinto il Gran premio della giuria all’ottantesima mostra del cinema di Venezia. “Quasi tutti i miei film sono basati su storie vere, è quello che faccio da sempre. Il mio sforzo è di non perdere la soggettività, provando a trasformare una storia in qualcosa di più universale”.
“In questo caso l’operazione è stata più difficile – sia per quanto riguarda la sceneggiatura sia per la regia – perché non avevo la distanza storica, non vedevo e non potevo vedere tutto l’arco della storia, i fatti stavano succedendo in quel momento. Ma allo stesso tempo ho pensato che il film avrebbe avuto un calore unico. È il primo che si occupa di questa frontiera, così mi è sembrato ancora più importante che fosse autentico”, racconta la regista, che in passato si era già occupata dell’idea di Europa e della sua ambiguità in Europa, Europa, la storia di due fratelli ebrei ambientata durante le persecuzioni naziste.
“Uno dei protagonisti del film e uno dei principali protagonisti di tutta la storia è la foresta, la natura è così potente che non riesci a pensare che sia un confine”, spiega Holland, che ha girato il film nella foresta di Białowieża, l’ultimo lembo della foresta vergine che un tempo ricopriva l’intero continente europeo. Il territorio è rimasto com’era perché era usato come riserva di caccia dello zar. Ora ricopre una parte della Polonia, della Bielorussia e dell’Ucraina.
“Attraversare la foresta e starci dentro è qualcosa che è connesso con le origini stesse dell’Europa e della storia del continente, la foresta porta con sé un’infinità di significati: è insieme pericolo e meraviglia. Anche dal punto di vista cinematografico è uno strumento molto espressivo, interpreta bene l’ambiguità dell’Europa. Da una parte il continente è la culla dei diritti umani, della democrazia, ma d’altra parte è stato ed è autore di crimini contro l’umanità”.
Per realizzare un film così direttamente legato alla realtà, Holland si è servita di attori che hanno davvero un background migratorio: sono attori professionisti, ma sono anche rifugiati. Jalal Altawil, che interpreta il ruolo del padre nella famiglia di profughi siriani (Bashir) che è al centro del film, ha vissuto per anni in un campo profughi in Europa. Mentre Maja Ostaszewska, che interpreta l’attivista Julia, uno dei personaggi principali del film, è una famosa attrice polacca, ma è anche un’attivista e interpreta se stessa.
Nel film Julia è una delle tante volontarie che pattugliavano la foresta per cercare i profughi e aiutarli con il gruppo Grupa granica. Nella realtà è stata una delle portavoce del gruppo: gli attivisti hanno di fatto sfidato il governo polacco e hanno agito al limite di quello che era consentito, rischiando di finire in carcere.
“Gli attori sono stati anche dei consulenti durante le riprese: per questo sono credibili. Hanno saputo portare nel film le loro conoscenze”, spiega la regista. “È stato un film realizzato in tempi record: ho cominciato a scriverlo nell’ottobre 2021, quando la crisi al confine era cominciata da qualche mese. Abbiamo cominciato le riprese solo nel marzo 2023, e sei mesi dopo eravamo a Venezia. La post-produzione è stata molto veloce, anche se il materiale era tanto, abbiamo dovuto correre per partecipare alla Mostra del cinema di Venezia”, continua Holland.
Fin dal principio la scelta è stata quella di girare in bianco e nero: “Ci ha aiutato a risolvere alcuni problemi dovuti al fatto che abbiamo girato in diversi mesi dell’anno. Ma la vera ragione è artistica: volevo uno stile crudo, diretto, come quello di un documentario”. Inoltre, l’ha aiutata a trovare un collegamento con il passato: “Volevo qualcosa che ricordasse l’immaginario della seconda guerra mondiale, che è ancora molto forte in quella foresta”.
Holland è una dei tre registi europei che quest’anno hanno girato film importanti sulla migrazione, quasi in contemporanea. Io capitano di Matteo Garrone mostra l’origine del viaggio, il desiderio di partire di due ragazzi del Senegal. Ken Loach nel suo The Old Oak racconta invece cosa succede a chi è già arrivato in Europa, dopo avere attraversato la frontiera. Holland rimane sulla frontiera, anzi usa il cinema per mostrare quello che nella realtà è vietato documentare, la ferocia delle recinzioni costruite per segregare chi non è europeo da chi invece lo è. I tre film, visti insieme, sembrano quasi una trilogia su uno dei temi più importanti del presente.
“Le leggi internazionali e nazionali che avevamo scritto dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo le tragedie del nazismo e dell’olocausto, sembra che siano state dimenticate. Parliamo di immigrazione, ma in realtà stiamo parlando del futuro di questo continente e anche della natura democratica dei nostri governi, dello stato di diritto. Nel film volevo dare voce ai senza voce, un volto ai senza volto. È stato anche un modo per dire che il nostro futuro è in pericolo e che il continente sta cambiando velocemente”, spiega Holland.
TRAILER
CLIP